Immaginate di essere in un quartiere residenziale di una qualche provincia della Spagna centrale. Non una baraccopoli post-apocalittica o una fumosa città al neon. Il mondo fa già schifo così com’è. Qui si trova Alfonso. L’uomo è ormai avanti con gli anni. Si gode una pensione non misera, ma inferiore alle aspettative. Ora che le giornata sembrano lunghe e vuote sente più forte il peso della solitudine. Quasi rimpiange i tempi in cui aveva un’occupazione, un lavoro, un ruolo ben definito. Se fossero meno presi dalle loro vite, i suoi vicini si sarebbero forse resi conto di quello che gli va frullando in testa negli ultimi tempi. Potrebbe passare loro accanto con quella sua andatura a scatti e lo sguardo malinconico, rimanendo come in un cono d’ombra, senza che nessuno lo noti. Ma a dir la verità, è sempre più raro che esca di casa. Preferisce starsene lì dentro, confinato fra le mure amiche. Si direbbe una reclusione volontaria o una prigionia prolungata. Al contrario, da quella sua stanza si sente di avere la chiave di mondi inaccessibili, di avere davanti a sé un forziere di possibilità inesauribili. O almeno, è così che si sente quando lo schermo lo illumina e lo trasmuta in qualcosa di diverso.
Il tutto era iniziato quasi per caso. Mmorpg gli sembrava una sigla come un’altra, lo scherzo di uno che ha pigiato troppi tasti insieme. I videogiochi li aveva sempre reputati roba da ragazzini. La noia però era tanta e si decise di fare un tentativo. Così, tra le innumerevoli pubblicità tutti uguali, scelse quasi per caso di seguire un link in particolare. Il gioco si chiamava Amadis.
Anche adesso mentre apre per l’ennesima volta l’inventario del suo personaggio, tra scaglie di drago e armi strappate dalle mani di qualche gigante, lo meravigliano i dettagli più piccoli. Ad esempio, lo stesso inventario, che nel gioco è chiamato Tresor, trova sia una erudita citazione di Brunetto Latini Livres dou Tresor. Ma ne potrebbe citare altri. In fondo, era stata proprio l’ambientazione cavalleresca e medievaleggiante quello che l’aveva attirato. «Chi più di un cavaliere dovrebbe avere a che fare con le quest?», aveva pensato tra sé e sé. Non avendo orari o impegni, aveva avuto tutto il tempo per migliorare e migliorarsi, livellando con pazienza nelle aree giuste. Inizialmente aveva anche speso una piccola fortuna scoprendo i piaceri del pay to win, per poi smettere considerandola una vigliaccheria. Era stato preso come in un vortice, senza nemmeno rendersene conto era finito per troneggiare nei vari ranking. Era diventato qualcuno.
Accedere ad Amadis è per lui diventato quasi un rito, una specie di incantesimo, un castello di Atlante in cui sentirsi al sicuro. Ora è nelle pianure di Xeres e aspetta gli altri giocatori per un raid. Sente una voce familiare nelle cuffie che lo saluta. L’inglese è quello raffazzonato che si parla ovunque come una lingua franca. D’altronde, anche lui ha seguito la più stretta osservanza a questa nuova universalità e per nome ne ha scelto uno dal sapore anglofono: Sadshape. Si compiace di sentirlo pronunciato dal suo compagno di avventura, almeno quanto lo commuove aver trovato nuovi amici in ogni angolo del globo. Ancora una volta i limiti usuali vengono sconfitti. Così si ritrova da vecchio ad avere una nuova giovinezza, un nuovo ardire.
Attraverso la passione per Amadis gliene sono passate altre. Per seguire i riferimenti criptici dei suoi più giovani e interessanti amici ha scoperto un’intera cultura sotterranea. Se n’è abbeverato quasi fosse un elisir salvifico creato da un qualche stregone. Ogni giorno sente quella realtà fittizia sempre più vera, mentre la quotidianità si riduce a proiezione ed ombra della virtualità. «L’immaginario era l’alibi del reale, in un mondo dominato dal principio di realtà. Oggi è il reale che è diventato l’alibi del modello, in un universo retto dal principio di simulazione. Ed è paradossalmente il reale che è diventato oggi la nostra vera utopia – ma è un’utopia che non appartiene più all’ordine del possibile, perché non si può che sognarne come un oggetto perduto»[1]. Queste parole gli vengono in mente come uscite da un abisso, non si ricorda nemmeno né dove né quando le ha lette.
Ironicamente ci sono filoni interi tra libri, film e quant’altro che rappresentano la sua condizione: mondi virtuali che diventano seconde case, dove disadattati come lui diventano eroi. Nonostante ciò, nessuno di questi lo soddisfa. La simulazione si densifica fino a sostituire la realtà, ma è sempre specchio di quest’ultima. Anzi ne ripete gli stessi topoi e cliché. È agita dal di fuori. È un mondo secondario che serve come palestra e addestramento per il mondo primario. È quest’ultimo il vero fine di tutto. È il mondo reale che entra nella simulazione, non il contrario. Se ci si risveglia, ci si risveglia nella realtà. Ma alla fine cos’è la realtà? Potrebbe benissimo non essere altro che una proiezione di noi stessi, una simulazione del nostro cervello, una finzione da scegliere tra altre.
Avrebbe dovuto portare la simulazione nella cosiddetta realtà. Interpretare il suo personaggio come il suo vero io, essere per sempre quel Sadshape che è nel gioco. Un cavaliere errante che vive un’avventura dietro l’altra, disfacendo i torti e difendendo i più deboli, così da far rivivere lo spirito della cavalleria in questa maledetta età di ferro. Spegne Amadis, per riaccenderlo e riviverlo nella vita di sempre.
***
Potrebbe cominciare così un Don Chisciotte dei nostri tempi. In fondo, è soltanto un pregiudizio quello che riconosce ai libri una rispettabilità che altri media non hanno. Superata questa contraddizione, possiamo sostituire il polveroso piacere per la carta stampata con manie più moderne. Così Il cavaliere dalla triste figura si presta a infinite riscritture e potrebbe essere il perfetto protagonista di un racconto cyperpunk. Per certi versi lo è già. Don Chisciotte è un virus che si innesta nella matrice del reale, sovvertendola. I romanzi cavallereschi per i quali impazzisce sono già a tutti gli effetti una realtà virtuale. Non ce ne accorgiamo perché al posto che portarsi lui nella realtà virtuale, porta quest’ultima nella realtà di tutti i giorni. Hackera direttamente il mondo che lo circonda, anche se con alterne fortune.
Ci si potrebbe addirittura interrogare o meno sulla volontarietà della sua follia. È quello che fa Giovanni Papini:
Don Chisciotte è l’uomo stanco dell’usuale. Come gli scettici a fin di carriera l’uggisce la vita casalinga di povero dignitoso fra le sue donne e il curato. Tutta la sua vita compressa di provincia, che ha trovato scarsi sfoghi nella caccia e nella letteratura, gli pesa. Vuol darsi un po’ di bel tempo. La cavalleria appresa nei grandi romanzi gli offre la traccia colorita di una mascherata senza rischi. Uomo di lettere e d’esperienza capisce che senza un trampolino di finzione non potrà cambiare di punto in bianco la sua esistenza. Non vede, come strada innocua di liberazione, che la pazzia.[2]
Il punto è quindi che la sua pazzia sia «un trampolino di finzione», una simulazione. Don Chisciotte è un cosplayer che non smette i suoi panni. Abbiamo già qui, in anticipo di quattro secoli, quell’insieme di isolamento sociale, di frustrazione per il quotidiano, di voglia di evasione, di immersione in mondi immaginari, di oscillazione tra gioco e fissazione, che attribuiremmo a un certo tipo di dipendenza tecnologica.
Per Papini è soltanto un caso fortuito che Don Chisciotte ci sembri incarnare determinati valori:
vuol disfare i torti e difendere i deboli perché tale è la tradizione consegnata nelle gesta dei cavalieri. È un imitatore, ha dinanzi una galleria di modelli: se Amadigi fosse stato diverso, spietato e infedele, anch’egli sarebbe stato diverso.[3]
Volervi vedere qualcosa di più, quasi fosse la metafora di una qualche affermazione spirituale, significa falsificarlo:
tipico di questi errori profondi per brama e vanesia profondità è l’ormai vecchia leggenda che il Don Chisciotte sia un’edizione rifatta e figurata del tema medioevale del contrasto fra l’anima e il corpo. Il padrone scarnificato sarebbe lo spirito, l’ideale sempre contraddetto dal servitore obeso ch’è la carne e l’immondo reale. Tutte le spiegazioni mistiche del Don Chisciotte si riducono a questa: Don Chisciotte asceta, santo e pazzo; i suoi compagni saggi, filistei e mondani.[4]
In altre parole, il ricorso ai valori di nobiltà e cavalleria Don Chisciotte dice di richiamarsi non ha nulla di sostanziale. È parte della finzione scenica. Non a caso le sue azioni sconfessano qualsiasi tradizione cavalleresca o una reale attualizzazione di quei valori. Si fa armare cavaliere da un oste, scambia prostitute per dame, libera banditi e carica lancia in resta una processione sacra. Siamo poi nel Siglo de oro spagnolo, a voler fare la guerra non ci sarebbe che da chiedere.
Qui si potrebbe discutere della valenza contro-iniziatica dello stesso Don Chisciotte che essendo parodia della cavalleria, per quanto in buonafede, è una sovversione di quest’ultima, rendendolo immagine del fallimento di ogni approccio che voglia far rivivere una tradizione partendo da semplici fascinazioni esteriori, sentimentali e libresche. Quando cioè il reazionarismo si trasforma in negromanzia.
Ma il punto su cui vorremmo soffermarci è un altro, ovvero usare Don Chisciotte per indagare la crisi tra reale e immaginario. Siamo abituati a pensare questa frattura in termini semplicistici, con l’online che prende il posto dell’offline. Il web diventa una seconda pelle, un secondo mondo, un metaverso, quindi una metafisica. Non è solo la sostituzione della realtà di tutti i giorni con un dato artificiale, con una messinscena virtuale, c’è qualcosa di più. La realtà è un termine ambiguo già prima dell’avvento di internet. Come insegnano i filosofi da Kant in poi, il centro della conoscenza è l’io non l’oggetto, siamo noi a creare il nostro mondo o quantomeno filtrarlo attraverso la nostra soggettività. Ciò significa che la conoscenza è qualcosa di attivo e che la realtà o esiste per il soggetto o è una specie di nulla oscuro che presentiamo solamente, come una nebbia di guerra in un videogioco.
La realtà non è mai qualcosa di pacificato, un punto fermo da dare per scontato. Ciò spiega anche il successo di quei paradigmi per i quali la realtà sarebbe solamente una simulazione. Verrebbe da chiedersi: una simulazione fatta da chi? Se, infatti, presupponiamo un artefice diverso da quello del soggetto, si va a perdere la dimensione attiva e creativa della conoscenza. Verremmo agiti dal di fuori e – se ci pensiamo bene – è quanto accade quando viviamo i mondi virtuali di qualcun altro. Applicando unicamente un criterio veritativo alla questione reale/virtuale, rimarremmo quindi impantanati. Da un parte ridurremmo il reale a un dato di fatto, a qualcosa di passivo, dall’altra disconosceremmo il vero pericolo del virtuale, ovvero sostituirsi al singolo nella sua azione sul mondo, riducendo questa sua azione – ancora una volta – a qualcosa di passivo.
Il web offre solo l’illusione di una irrealtà, nascondendoci la sua materialità di cavi, schermi, server, processori. È una propaggine fantasmagorica del reale, non la sua negazione. Allo stesso modo, è compresso nella pura orizzontalità, cosa che ne spiega anche la sua estrema pervasività. Come scrive Andrea Venanzoni ne Il trono oscuro: «La fagocitazione dei codici umani e dell’universo da parte di un software demiurgico significa, infatti, semplicemente simulare la trascendenza del reale, per poi essere condannati a vivere nella mera sostituzione di un reale con un altro, per quanto virtualizzato»[5]. L’immagine virtuale non è un viatico per qualcosa di più alto, ma è un legame autoreferenziale. Ciò spiega anche il senso dipendenza e prigionia che si origina dal mondo di internet. Non c’è volontà di superamento, tutto si riduce ad un mascheramento o all’auto-inganno.
Possiamo prendere come esempio di quanto detto finora sul web il comportamento dello stesso Don Chisciotte. In quest’ultimo la riproposizione della cavalleria avviene solamente come finzione, peraltro auto-assolutoria, e non come una autentica attualizzazione. È un travestimento che vive di espedienti e riscritture solo superficiali del reale, fino a condurre a una prigione di specchi. Non a caso il primo volume si conclude con il nostro protagonista che viene ridotto in catene e riportato a casa. La sua fuga fallisce, perché appunto una fuga e non una carica di cavalleria. L’incapacità qui non è semplicemente nel mezzo, sia esso il mondo virtuale di internet o quello dei romanzi cavallereschi, ma nel non riuscire a tradurre la potenza in atto – e in fondo il virtuale non è altro che ciò che esiste soltanto in potenza.
L’atteggiamento di quest’ultimo è comunque migliore di quel grossolano principio di realtà, di quello spirito di gravità che è Sancho Panza. Se almeno in Don Chisciotte c’è un’aspirazione demiurgica a re-immaginare il mondo, per quanto illusoria, Sancho Panza accetta passivamente quanto ha davanti, finendo per essere il più credulone dei due, tanto da prestare fede alle promesse del primo. La sua pretesa di felicità ci sembra forse più realistica della sete di giustizia di Don Chisciotte, ma lo è solamente perché più comune. Sancho Panza è l’utente medio di un qualsiasi social network. Ha appetiti semplici, fantastica di vivere esperienze autentiche, come quelle che gli intasano il feed e lo riempono di aspettative, ma sono immagini falsate. E mentre si perde in questo sogno di lusso generalizzato nemmeno sia accorge quanto la realtà stessa gli si sia fatta lontana, tanto da apparire un miraggio.
Michele Iozzino
[1] J. Baudrillard, Cyberfilosofia, Mimesis, Milano-Udine, 2010, p. 10.
[2] G. Papini, Testimonianze, Studio Editoriale Lombardo, Milano, 1918, p. 217.
[3] Ivi, p. 214.
[4] Ivi, p. 213.
[5] A. Venanzoni, Il trono oscuro, Luiss, Roma, 2022, p. 128.


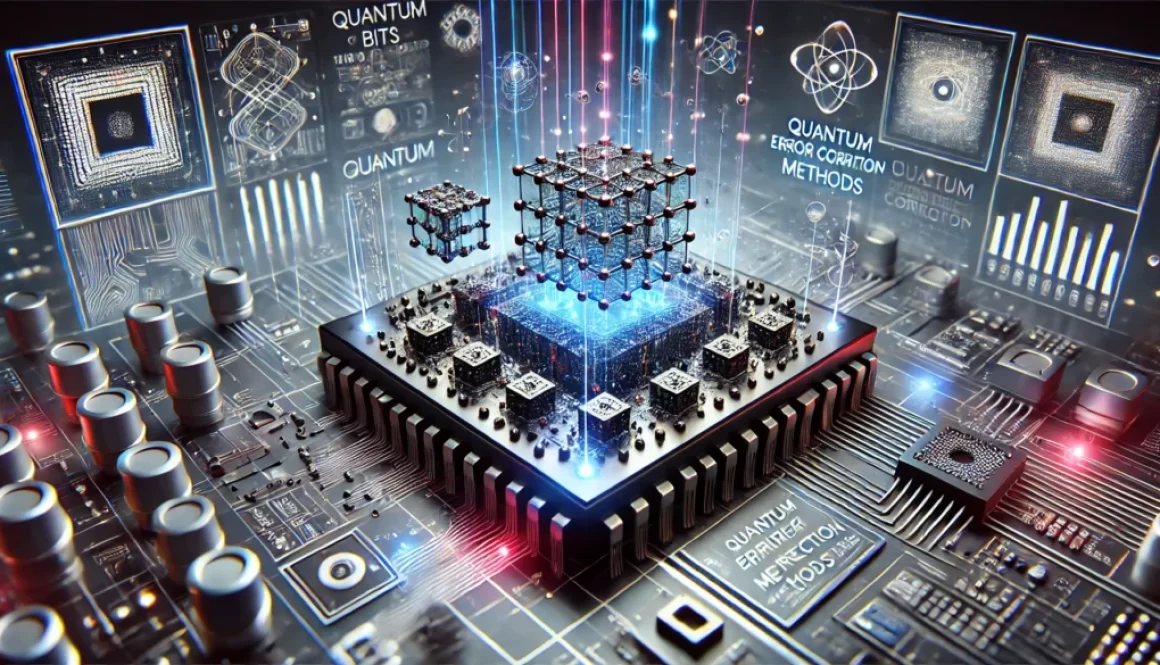




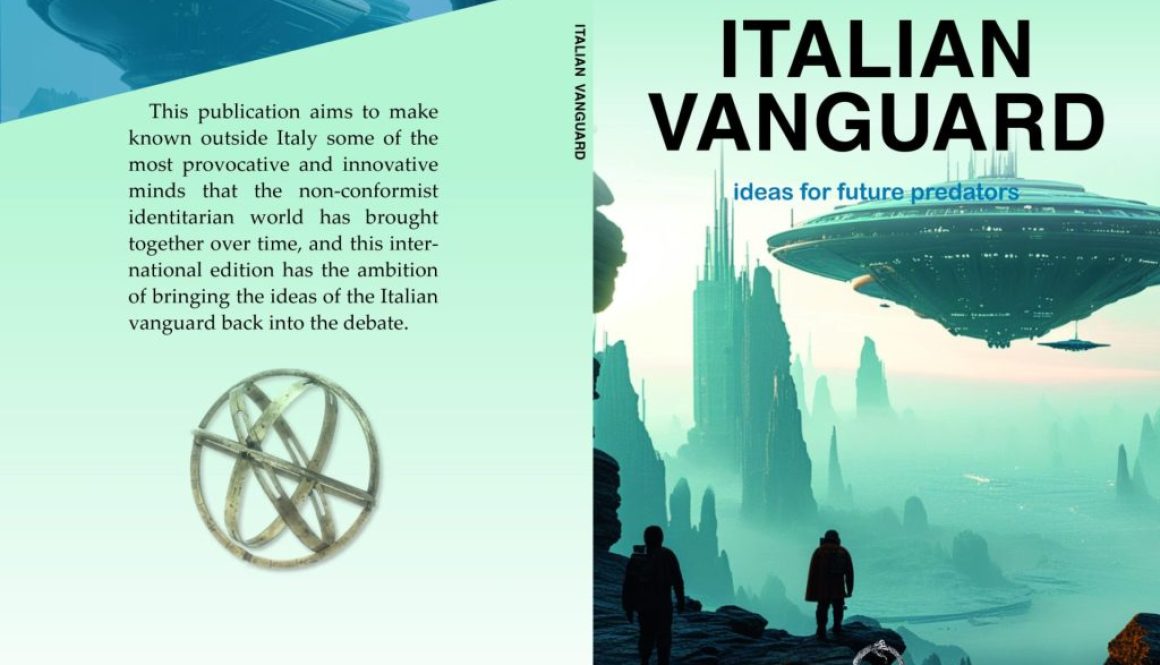


 iva dichiarato la fonte di ogni creazione di valore, “i lavoratori” potevano essere trasfigurati in creatori di mondi par excellence». Echi jüngeriani che sembrano richiamare direttamente uno scritto fondamentale come L’operaio. Tutto ciò regge almeno finché si è immersi tra i fumi dell’Ottocento, con il loro fascino steampunk e fin de siècle. Nella post-modernità la faccenda sembra rovesciarsi per eccesso e tale spinta eroica si trasforma in qualcosa di detestabile: un rogo che brucia se stesso e il mondo intero. Il Prometeo che aveva spezzato le catene ora finisce per vergognarsi fino al punto provare rimorso di fronte allo scenario attuale, ovvero quello del cambiamento climatico.
iva dichiarato la fonte di ogni creazione di valore, “i lavoratori” potevano essere trasfigurati in creatori di mondi par excellence». Echi jüngeriani che sembrano richiamare direttamente uno scritto fondamentale come L’operaio. Tutto ciò regge almeno finché si è immersi tra i fumi dell’Ottocento, con il loro fascino steampunk e fin de siècle. Nella post-modernità la faccenda sembra rovesciarsi per eccesso e tale spinta eroica si trasforma in qualcosa di detestabile: un rogo che brucia se stesso e il mondo intero. Il Prometeo che aveva spezzato le catene ora finisce per vergognarsi fino al punto provare rimorso di fronte allo scenario attuale, ovvero quello del cambiamento climatico.